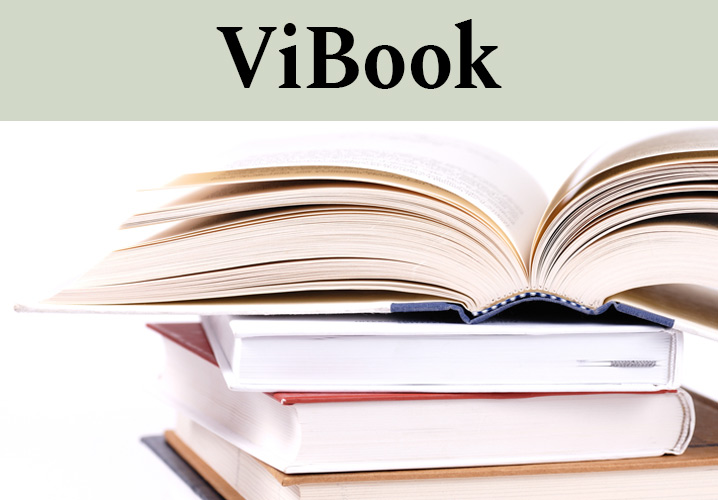Quand’ero uno sfaccendato che cercava di capire il mondo con tutta l’arroganza della primavera della vita mi avvicinavo anche a gente pericolosa, che faceva paura. Per mia fortuna la loro cattiveria era solo una barriera difensiva. Non erano realmente cattivi o, per lo meno, erano cattivi solo quando qualche loro necessità lo imponeva. Una sera, durante uno dei miei pellegrinaggi estivi, capitai in una betola infame, un posto da bassifondi della campagna veneta, nel buio violento della metà degli anni ’80 del XX secolo. La strada per arrivarci era sterrata e correva in mezzo a due canali. Il posto, più che un bar, era un covo di vecchi contrabbandieri e rapinatori. All’interno i faccendieri se ne stavano in disparte finché non capitava qualche pollo da spennare. Il soffitto era in legno, dello stesso legno del bancone ad angolo, con dietro una tipa truccata troppo da una parte del volto, come se nascondesse un livido. C’erano cinque o sei tavoli e un divano rosso scuro, quasi marrone. Il salone era largo perché in mezzo qualcuno ci ballava, al ritmo delle canzoni da disco italiane degli anni ’70, sempre del XX secolo. Il tizio di fronte al bancone avrà avuto 40 anni, il doppio della mia età, ed era anche il doppio di me. Aveva la punta dell’orecchio sinistro mozzata e non ti guardava mai negli occhi. Appena mi avvicinai al banco per chiedere da bere mi disse, con un accento tra il veneziano e il padovano: “Fìo sta calmo che ti vivi più de mi” poi buttò giù il mezzo bicchiere di sambuca e aggiunse: “Forse…”, scoppiando a ridere e facendo ridere anche i suoi amici tagliagole al banco. Allora mi avvicinai al bancone e dissi alla tipa che offrivo da bere a tutti. La barista con un cenno del capo indicò il tipo al bancone che si voltò verso di me e mi disse: “Cossa xe che ti vol?”. “Solo imparare” risposi io seraficamente. “Allora si ti vol imparare, va casa e torna qua si te vol imparar”. Il messaggio era chiaro e decisi di tagliare la corda. Lo salutai e raggiunsi l’uscita, sotto gli sguardi apparentemente indifferenti dei presenti, accompagnato da un pezzo hard-melodico di Eros Sarmaga, un cantante locale. Varcai la porta e mi incamminai verso la macchina che avevo parcheggiato a un centinaio di metri da lì. In fondo c’era il riflesso della luna, quasi piena, sui due canali. La striscia di terra che li divideva sembrava la riga dei capelli di una divinità acquatica sommersa. Davanti c’era il nulla, immerso nell’oscurità e, alle mie spalle, la luce purpurea e vibrante della betola che usciva dalla porta come un richiamo malefico, una pulsazione che il buio riusciva a malapena a inghiottire. Arrivai al punto dove avevo parcheggiato la macchina. E non la trovai.

Le avventure di “Mutanda Verde”
Non pensate a me come a un supereroe in costume. Sono praticamente invulnerable, ho la forza di 10mila uomini, so