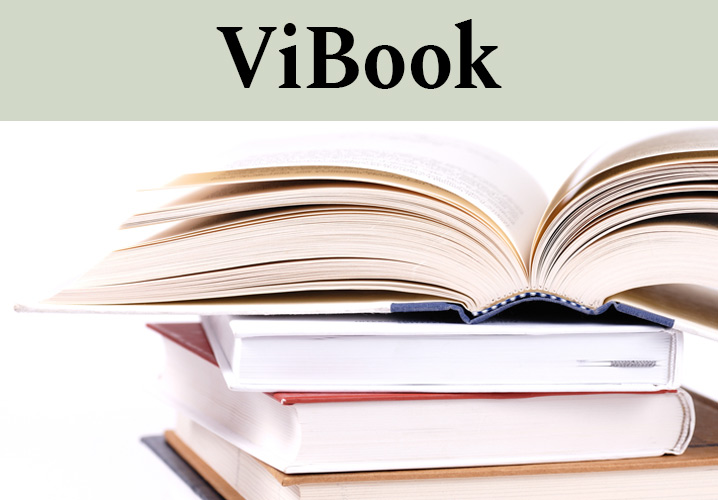Succede che ad un certo punto, quando dicembre ci stava portando verso le feste, al direttore di TVA Vicenza viene in mente di proporre un dialogo tra colleghi, una riflessione a due sullo stato delle cose in città. Un’occasione per parlare di cosa potrebbe essere Vicenza, di cosa vorremmo noi dalla città e di quali e quante possibilità la città ha e non sfrutta. Da quel momento inizia uno scambio di mail tra Gianmarco Mancassola e Marco Ghiotto, che dirige il foglio virtuale che leggete. Riportiamo qui il dibattito epistolare. Quel che ne esce è il disegno dolceamaro di una situazione stantia ma anche il desiderio e la convinzione si possa dare un giro di vite.

Gianmarco Mancassola, 12 dicembre:
Allora, Marco, parto da una cosa piccola, marginale, in apparenza trascurabile. Qualche giorno fa stavo correndo tra la Valletta del Silenzio e Monte Berico. Era un giorno di nebbia agli irti colli, perforata da lame di sole. Questo pezzo di Vicenza da solo meriterebbe di finire in una Lonely Planet. Mentre sto girando intorno a Villa ai Nani, nella bruma noto un foglio di carta appeso a uno dei cancelli laterali. È né più né meno che un foglio di carta scritto a pennarello, come quelli che lasciano i bottegai quando escono per un caffè: “Torno subito”, quelle cose lì. Su questo c’era un avviso per il corriere espresso e diceva quello che dicono tutti questi avvisi: se suoni e non rispondo, lascia pure il pacco accanto al muro. Morale: i pacchi sono democratici, davvero, che tu sia un venditore di pentole o un nobile di antico lignaggio proprietario di una dimora cinquecentesca. Bon, tutto qui. Chissenefrega, mi dirai tu. E probabilmente avresti anche ragione. Però, non trovi che dietro quel foglio di carta ci sia qualcosa di più, alludo a uno stato d’animo, un senso di imbarazzo e di impotenza che è la condizione di una città come Vicenza che ogni giorno deve vivere in equilibrio instabile sulla linea d’ombra tra la sua bellezza, che ha ereditato dal passato ormai remoto, e la sua corsa spesso affannata per essere attuale, per non perdere il passo dentro il tempo presente? È il conflitto tra la città-museo e la città-impresa, che di rado ha trovato un compromesso. Palladio e Amazon devono convivere se vuoi continuare a vivere: già, ma come? Se rispondi a questa domanda hai la chiave per creare sviluppo. Altrimenti, o resti fermo o fai danni. Penso ai pannelli fotovoltaici sui tetti del centro storico o ai nasi arricciati per i dehors dei bar in Corso, oppure agli autobus in Ztl, alla musica nelle piazze d’estate e avanti così pressoché all’infinito. Possiamo far finta di nulla e sorridere davanti al foglietto di carta, oppure immaginare Tiepolo e Jeff Bezos seduti allo stesso tavolo impegnati a trovare un compromesso tra bello e utile, tra antico e contemporaneo, tra museo e impresa. È come se Vicenza avesse due cervelli: con il primo pensa a proteggersi le spalle, con il secondo prova a stare nella contemporaneità. Ma così sembra una fatica assurda: dovremmo riuscire a pensare con un cervello soltanto. O sbaglio?
Marco Ghiotto, 13 dicembre:
Caro Gianmarco, siamo sempre lì, alla famosa e ricercata identità. Non sbagli. Il problema secondo me sta sempre in quello che ci raccontiamo e non è un problema vicentino ma nazionale. Sono anni che conta più quel che si dice di quel che si fa, siamo diventati una sorta di società controfattuale. La narrazione (termine che ormai non sopporto più) ci dice che Vicenza è una città bellissima con enormi potenzialità eccetera eccetera. Ma siamo sicuri sia vero? Io vedo una città in crisi da decenni ormai. Una città che è diventata grigia, un po’ sciatta, in cui il decoro urbano è un problema. Una città che perde abitanti, che ha un centro sempre più piccolo, che non riesce a crescere il suo standing. Un esempio banalissimo? In pieno covid a Rovigo aprì una splendida mostra su Chagall che ebbe un grande successo. Dico, a Rovigo, che con tutto il rispetto non è la prima città turistica veneta. Cosa manca quindi? Il coraggio e la visione direi. Perché possiamo stare qui ore a parlare di identità ma se poi non si sa che fare o non si hanno le motivazioni per prendere delle scelte, rimaniamo sempre al palo. Esempio degli esempi è Palladio. Non fraintendermi, non voglio dire che il brand Palladio abbia stancato, però è paradossalmente sovraesposto e allo stesso tempo sfruttato poco e male. Ricordo che poco tempo fa si voleva Vicenza come città dell’architettura. Ma chi lo sosteneva si era fatto un giro nei quartieri? Nella primissima periferia? O anche solo nelle nuove costruzioni del centro, per non parlare dei nuovi monumenti? Siamo circondati da brutture che farebbero soffrire enormemente l’esimio architetto se tornasse tra noi. Eppure non lo si dice o non si vuole vederlo. Perché ci raccontiamo che siamo una città bellissima, perché l’ha detto Goethe e così è in secula seculorum. Come possiamo quindi pensarci qualcosa di diverso se non sappiamo nemmeno vedere cosa siamo ora? Qui il problema è culturale. Serve una forte, sana dose di realismo. Poi possiamo discutere. Tu mi parli di una città contemporanea, in cui l’innovazione entri nei progetti quotidiani, con una visione europea. Palladio e Amazon sono molto più simili di quanto si pensi. Rappresentano quel mondo che va avanti, che crea, che rompe barriere, che porta modernità. Non ti so dire come possano convivere ma sono convinto che si debba investire nello stesso modo sia sulla conservazione che sull’innovazione, perché una città come la nostra non può essere sbilanciata solo da un lato. Certo, per fare questo, occorre prima cambiare mentalità.
Gianmarco Mancassola, 16 dicembre:
Ecco, mentalità. Vale a dire processi culturali. Vicenza ha un luogo che potrebbe essere uno straordinario motore di riflessioni e, quando ti va bene, cambiamenti culturali. Alludo al teatro Olimpico. Da troppo tempo in quel tempio si professa una fede che non è praticata fuori dalle mura palladiane. Quello che accade sul palco non ha riflessi sulla scuola, sulla politica, sull’economia. Vanno in scena spettacoli che riscuotono un gradimento più o meno intenso, ma non incidono sulle nostre vite, durano il tempo di una serata, poi svaniscono nel nulla. La stagione dei classici manca di allure nazionale: non se la fila nessuno al di fuori del contado vicentino. Manca di glamour: non c’è nemmeno un red carpet, il pubblico viene fatto entrare da una via laterale male illuminata, su un lato le pareti scrostate dell’odeo, sull’altro madri che sgrullano le tovaglie dai ballatoi di palazzine che voltano le spalle al teatro, offrendo il lato B di garage e biancheria stesa ad asciugare. Abbiamo detto del confronto irrisolto tra città antica e città moderna: perché non provare a rappresentarlo sul palco dell’Olimpico? Il nostro tempo non può eludere una riflessione sulla tecnologia, sulla transizione tra l’era analogica, durata millenni di civiltà, e l’era digitale, compressa in pochi decenni che ci è toccato in sorte di attraversare spesso a occhi chiusi, senza una bussola, una mappa, una torcia per orientarci. Perché tutto questo non può essere messo in scena all’Olimpico? Non sono forse già da considerare classici autori come Philip Dick, Ray Bradbury, Arthur Clarke, Isaac Asimov, George Orwell, Aldous Huxley? Le vie di Tebe non sono così lontane dai bastioni di Orione: perché non possiamo portare l’occhio rosso di Hal 9000 nel teatro dei teatri? Christopher Nolan ha (ri)portato milioni di spettatori al cinema con la storia di uno scienziato fino a ieri privo di fascino e per nulla pop come Robert Oppenheimer. Ci è riuscito perché ha raccontato una tragedia moderna eppure classica, che parla di noi tutti nei secoli dei secoli, ma anche di noi tutti oggi, in questo esatto momento. Oppenheimer è Prometeo, è Galileo, è Faust, è Steve Jobs. A me l’Olimpico sembra perfetto per allestire un grande specchio in cui riflettere le nostre paure, le nostre ansie, il nostro smarrimento. Iniziamo a cercare il Nolan del teatro, che dici?
Marco Ghiotto, 18 dicembre:
In teoria già il Teatro Olimpico potrebbe essere il Nolan di se stesso. Il concetto di “classico” però dovrebbe essere se non ripensato tout court, almeno corretto e reso malleabile. Io sono convinto che la “sacralità” dell’Olimpico sia intoccabile e che quindi non si debba osare troppo, ma al contempo penso che ci siano classici contemporanei che possono, anzi devono, poter calcare quella scena. Declinare la classicità significa andare in profondità nei contenuti e nelle epoche, senza per questo scostarsi dall’origine. Un classico contemporaneo ha sempre l’afflato universale di qualcosa che sia monumento di una civiltà. Per usare le parole di Calvino “è classico ciò che tende a relegare l’attualità al rango di rumore di fondo, ma nello stesso tempo di questo rumore di fondo non può fare a meno”. Esiste quindi un repertorio enorme di teatro classico “nuovo” che diverrebbe specchio storico e generazionale e si inserirebbe con totale coerenza nell’Olimpico. Ma perché il Teatro sia Nolan di se stesso serve, come dici giustamente, anche un rinnovamento estetico e logistico. L’entrata va come minimo ripensata. Non sono un fan dei tappeti rossi ma l’accesso al capolavoro palladiano dalla strada laterale è mortificante. Non sono nemmeno un grande fan dello storytelling di Baricco realizzato anni fa, però un’operazione di marketing per l’Olimpico era e rimane indispensabile. E non trovi sia sintomatico (e qui torniamo a quanto detto prima) che avendo noi Palladio come simbolo assoluto, siamo qui a dire che quel simbolo va comunque spinto e sostenuto in maniera diversa, più innovativa e tecnologicamente avanzata? La visione, caro Gianmarco. È la visione di un progetto, di uno spazio, di una città, quella che fa la differenza. Non di certo i passi obbligati o le toppe last minute. Una visione che pare mancare da troppi anni in centro storico ad esempio. Ormai si va indietro di 30 anni nel ricordare lo splendore reale del centro di Vicenza. Ma poi? Il centro si sta spopolando sempre più, imbruttendo, riducendo ai soliti pochi luoghi. Penso alla zona Eretenio, Campo Marzo, Santa Caterina, ma solo giusto per fare un esempio. Quanta bellezza abbandonata, di fatto. Penso anche alla zona ex tribunale (io non ho mai creduto sia possibile là fare una biblioteca) e a come non si sia pensato di mettere mano alle ex carceri. Penso alle scelte di spostare il tribunale, di spostare alcuni uffici, di non risolvere la voragine Cinema Corso, Banca d’Italia, Camera di Commercio, che lascia una intera zona senza cure. Una costante crisi di idee o di scelte sbagliate che dura da troppo… Si riparta dal centro storico, lo si ricrei bomboniera perfetta com’era un tempo.
Gianmarco Mancassola, 19 dicembre:
Il teatro Olimpico è la prima vittima di un centro storico avvitato su se stesso. Si affaccia su una non-piazza, che per un pezzo è area pedonale, per un pezzo giardino pubblico, per un pezzo strada carrabile, per un pezzo parcheggio. Cos’è piazza Matteotti? Non ha identità, troppi luoghi in uno solo, quindi un non-luogo come le stazioni e gli aeroporti. Andrebbe eliminato il parcheggio, un’oscenità. Andrebbe spostata la statua di Fedele Lampertico, andrebbe sacrificata l’aiuola, andrebbe sostituito l’asfalto con i sanpietrini, andrebbe chiuso il traffico di bus e corrieri espressi. Corso Palladio dovrebbe sbocciare proprio dalla piazza del teatro: possibile che a un progetto così banale non siamo riusciti a destinare nemmeno un euro del Pnrr? Eppure chi viene a Vicenza viene soprattutto per l’Olimpico. E fatica a trovarlo. Il centro è buio, la raccolta dei rifiuti all’ora di cena è mortificante per i ristoranti, piazza Castello è stata stuprata con transenne che impongono ai visitatori cervellotiche gimcane, non riusciamo ad alleggerire il carico dei bus dentro le mura, da tempo Vicenza non è più sexy agli occhi delle griffe e dei grandi marchi di moda, ci sono strade centralissime rimaste ormai senza linfa commerciale. Non è colpa di nessuno, o forse è colpa di tutti: i vicentini sembrano i primi a non voler credere fino in fondo nella città in cui vivono e lavorano.
Marco Ghiotto, 20 dicembre:
Pochi giorni fa sui social c’era un post di una donna che chiedeva consigli ai vicentini. Voleva trasferirsi qui e necessitava di opinioni sul come si vive in città. Apriti cielo. Il 90% delle risposte era di un negativo assoluto. Ovviamente ben oltre il reale stato delle cose. E io mi chiedo: ma che percezione distorta abbiamo di noi stessi, sempre e comunque? E qui torniamo alla narrazione di cui parlavamo prima. O ci diciamo che è la città più bella del mondo o ne parliamo come di un luogo di degrado massimo. Realismo questo sconosciuto. Il fatto è che, più che Vicenza, mi accorgo che il problema ce l’hanno i vicentini. La democrazia partecipata è un’idea bellissima ma qui non ci si mette d’accordo praticamente su nulla se non siamo, alla base, d’accordo su cosa vogliamo dalla nostra città, su come la vogliamo. Prima che sia troppo tardi io credo sia il momento di osare, di rischiare, perché ho la netta sensazione che le sabbie mobili in cui poggiamo i piedi da ormai 20 anni stiano diventando cemento. Il mondo non è mai stato così diverso rispetto a cinquant’anni prima come lo è adesso. Nemmeno quando è stata inventata l’elettricità. Dobbiamo per forza essere moderni, a costo di scontrarci con la nostra atavica provincialità. Vicenza è una piccola città a vocazione conservativa, con solide basi di rancori, permeata su un perbenismo di facciata e più che eccellente nell’arte del pettegolezzo. A Vicenza se fai qualcosa sbagli, se non lo fai è pure molto peggio. Ecco, serve fare qualcosa senza (aver paura di) sbagliare.
Gianmarco Mancassola, 21 dicembre:
E allora va bene anche imbastire la recinzione di un lato di Campo Marzo, pur di provare a smuovere la palude dell’immobilismo. Vicenza fatica anche a celebrare se stessa. Non ha un premio per i suoi migliori figli: ce l’ha Bassano, ce l’ha persino Sandrigo, che ha preso a prestito persino simbolo e nome della Basilica per conferirlo. Non ha un percorso che valorizzi il turismo sportivo: c’è un brand nazionale come il Lanerossi, la Nobile provinciale, con due palloni d’oro come nessun’altra città di queste dimensioni, eppure in corso Palladio non c’è non dico un museo, ma nemmeno uno store biancorosso. Non c’è un itinerario dei piatti tipici, del baccalà alla vicentina: ci sono giorni o sere in cui mangiare un piatto di polenta e baccalà rischia di diventare una caccia al tesoro. Rovigo, nel suo piccolo, ha messo in piedi mostre capaci di attrarre visitatori da tutto il Nordest. Qui ancora si discute sui Van Gogh portati da Marco Goldin, quasi fosse stata una caduta di stile nella torre eburnea della purezza palladiana. E poi la letteratura. Sono vicentini tre giganti nel Novecento italiano: Goffredo Parise, Luigi Meneghello, Mario Rigoni Stern. Eppure è come se non ce ne ricordassimo. A Parise è stato intitolato un canton sconto del centro storico, di questi giorni è la polemica (giusta) per l’intenzione di dedicare la nuova bretella dell’Albera al poeta Fernando Bandini. La toponomastica dovrebbe avere la funzione delle pietre d’inciampo, sperando di non suonare irriverente. Obbligano chi vive, chi lavora, chi passa per quella via o piazza a chiedersi chi fossero il tizio o la tizia a cui sono dedicate. Ma ci vuole un criterio. Dice: eh, ma da un po’ non si fanno più strade nuove. Già questo è un indice di una città ingessata, che non cresce, che è ripiegata su se stessa. Ma allora cerchiamo di essere creativi. Ci sono numerose scuole che portano il nome della via su cui sorgono, come la Riello, oppure si ritrovano con il nome di un santo appicciato addosso. E allora, perché non intitolare a grandi figure della cultura vicentina le scuole rimaste anonime? Perché non creare un percorso cultura contemporanea che faccia viaggiare i nostri figli oltre Dante e Manzoni? Una scuola intitolata all’autore de “I piccoli maestri”: non sarebbe bellissimo e rivoluzionario? E a proposito di rivoluzioni: se siamo alla ricerca di un nome per battezzare la tangenziale ovest, facciamo un gesto politico, gridiamo un inno alla libertà e alla democrazia, issiamo la parola Ucraina sui cartelli di quel pezzo di città che punta verso nord: viale Ucraina, magari persino viale Ucraina libera. Non sarebbe un colpo di pettine a costo zero sul ciuffo inamidato di questa città?
Marco Ghiotto, 22 dicembre:
Mi trovi allineato totalmente sull’idea di viale Ucraina. Una scelta di campo, un messaggio forte e identitario, soprattutto un giro di vite all’eterno democristianesimo berico. Ucraina (e Ucraina libera) vuole oggi dire speranza, vuol dire credere nell’Europa, vuol dire smetterla con le pagliacciate propinateci dagli amici di Putin, vuol dire pensare al domani e quindi vuol dire giovani. Quei giovani che possono essere davvero il tema su cui ripensare la città. A pensarci bene, tutto quello che ci stiamo dicendo ruota attorno ai concetti di modernità, di restyling, di attrattività, di visione e allora ci si imponga l’obbiettivo di essere città giovane. Sarebbe una vera rivoluzione. Vorrebbe dire superare gli steccati ideologici (e antropologici) che ci impediscono da decenni di stare al passo con quanto ci accade attorno. Musica, arte, festival, luoghi di aggregazione, e poi grande spazio alle tecnologie, alle start up innovative, ai temi ambientali, alla partecipazione. E quindi viva l’Ucraina libera, che diventa simbolo di presa di posizione netta in questo presente per molti versi pauroso. Avere un primo cittadino giovane (e in particolar modo questo primo cittadino) mi fa ben sperare. Avere una giunta giovane mi fa ben sperare. Che di sperare, caro Gianmarco, abbiam proprio bisogno.
Marco Ghiotto, 23 dicembre:
P.S. dimenticavo una cosa fondamentale. Dobbiamo sempre ricordarci che se è vero che la bellezza salverà il mondo (e il principe Myskin acconsente, senza averlo mai detto) è fondamentale, prima, che la bellezza sia salvata. Un particolare di cui ci si dimentica troppo spesso…