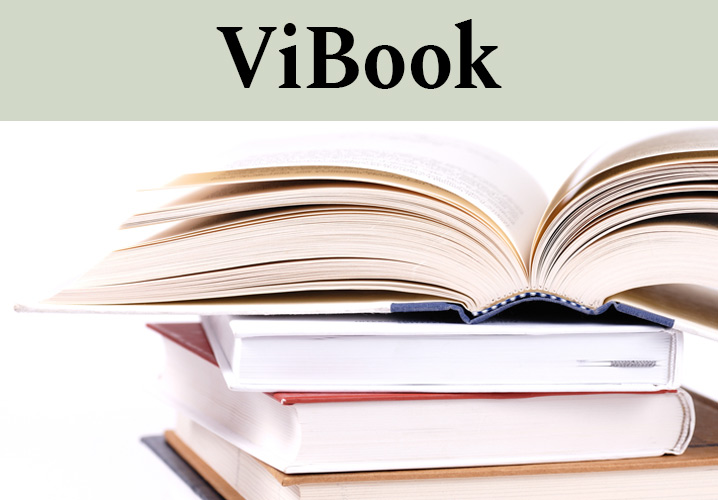Melt the guns, and never more to fire them – XTC, 1982
Eteocle e Polinice, figli di Edipo, si erano accordati per spartirsi il potere sulla città di Tebe; avrebbero regnato un anno a testa, alternandosi sul trono. Eteocle tuttavia allo scadere del proprio anno non aveva voluto lasciare il proprio posto, sicché Polinice decide di dichiarare guerra al proprio fratello e alla propria patria, presidiando le sette porte della città di Tebe con sette dei suoi più forti guerrieri, ed il settimo è proprio lui, Polinice, che andrà verso un fatale fratricidio. Gabriele Vacis, che torna dopo uno splendido Prometeo l’anno scorso, porta in scena un Eschilo che gli serve per raccontare l’insensatezza folle della guerra e al tempo stesso la propria inscindibilità dalla storia dell’uomo. Un contrasto apparentemente irrisolvibile se non, forse, con una rivoluzione che metta al centro l’individuo. E questo accade negli 80 minuti di spettacolo, tesi, intensi, laceranti.

War, children, it’s just a shot away – Rolling Stones, 1971
Sul palco, un corpo unico che si muove, danza, piroetta, duella con se stesso, e canta un canto ancestrale, figlio del bisogno di comunicare con gli dei, con il centro della terra. Si alzano canti antichi, in lingue diverse. Spicca “Sidun”, che De Andrè scrisse parlando del bombardamento sulla città libanese di Sidone, ed in cui inserisce l’immagine della fine civile e culturale di un piccolo paese: il Libano, la Fenicia, che nella sua discrezione è stata forse la più grande nutrice della civiltà mediterranea. Ecco l’insensatezza della guerra, ecco la tragedia massima della morte per mano di un altro uomo. Perché di esseri umani si parla, non di una coreografia, non di un simbolismo d’effetto, non di speculazioni filosofiche. Il modo laboratoriale che è la base del lavorare di Vacis, trova pieno compimento in questo lavoro talmente stratificato da avere quasi troppa materia da svolgere. Eppure i suoi magnifici 12 ragazzi meritano tutto quello che si conquistano sul palco. Molti di loro sono “ragazzi del ’99”, oggi 24enni ed in qualche modo epigoni dei coscritti di leva italiani alla fine della grande guerra. Il paragone non è offensivo e tantomeno enfatico, e infatti, dopo aver spostato l’azione da Tebe al qui ed ora, ecco che in cerchio dicono “Io sono vivo” e si presentano, con le loro storie, il loro particolare, il loro io fondamentale e sacro. Sacro come il sangue di ognuno di noi. Eppure, non tutto il sangue è uguale. La guerra la fanno gli uomini, mentre le donne, nel coro, attendono e disperano. E qui Vacis rovescia il piano dei significati e dona verità carnale al dolore vissuto e fa dire alla donna quanto lei abbia dimestichezza naturale col sangue per il ciclo mestruale e il parto mentre l’uomo lo incontra solo con la violenza e lo cerca con la guerra, come se l’umanità tutta dovesse sanguinare per sentirsi viva.

Stop children, what’s that sound? Everybody look, what’s going down? – Buffalo Springfield, 1966
Perché l’uomo soffre? Da dove arriva agli uomini il dolore? Viene solo dalla loro condizione di mortali, come affermavano i poeti arcaici, o da un errore originario, scontato dall’intera umanità, come è l’errore di Prometeo in Esiodo? Oppure all’interno della condizione umana esiste anche la responsabilità del singolo individuo? Quaerebam unde malum et non erat exitus, diceva Sant’Agostino. Il problema del male, visto nella sua complessità, e nella sua assurdità rispetto alla nostra unilaterale razionalità, diventa ossessionante. Esiste uno splendido carteggio tra Einstein e Freud su questo tema. Lo scienziato incalza lo psicoanalista così: “com’è possibile che la massa si lasci infiammare fino al furore e all’olocausto di sé? Una sola risposta si impone: perché l’uomo ha dentro di sé il piacere di odiare e di distruggere”. Al che Freud risponde: “Quanto dovremo aspettare perché anche gli altri diventino pacifisti? Non si può dirlo, ma forse non è una speranza utopistica che l’influsso di due fattori – un atteggiamento più civile e il giustificato timore degli effetti di una guerra futura – ponga fine alle guerre in un prossimo avvenire. Per quali vie dirette o traverse non possiamo indovinarlo. Nel frattempo possiamo dirci: tutto ciò che promuove l’evoluzione civile lavora anche contro la guerra”.

And I swear that I don’t have a gun – Nirvana, 1991
Se c’è una cosa, tra tutte, tra le tantissime di cui è composto questo spettacolo, che colpisce nel modo più corretto per riportare passato e presente sulla stessa linea, è l’incursione di uno degli attori in mezzo alla storia, per descrivere di volta in volta un’arma moderna. Dall’italianissima Beretta al fucile d’assalto M16. Gabriele Vacis eleva la narrazione ad un livello in cui azione, recita, divulgazione e coscienza sociale, si uniscono in un solo orizzonte. Forse anche per questo il pubblico si sente parte integrante del tutto, come fosse attivo nel ruolo di confidente. Un grande inizio per questa stagione dei classici all’olimpico. La sera dopo, trovo tutto il cast al bar, due ore prima dello spettacolo. Vivi e leggeri come una freccia già scoccata. Poi, dopo cena, a spettacolo abbondantemente finito, mentre rincaso, incontro uno di loro, ci riconosciamo, parliamo un po’ e alla fine, salutandoci, ci abbracciamo. Perché i classici sono anche questa cosa qua: sono vivere diversamente la città, in un’altra dimensione, e calarsi dentro ad un’umanità salvifica e all’arte dell’incontro.