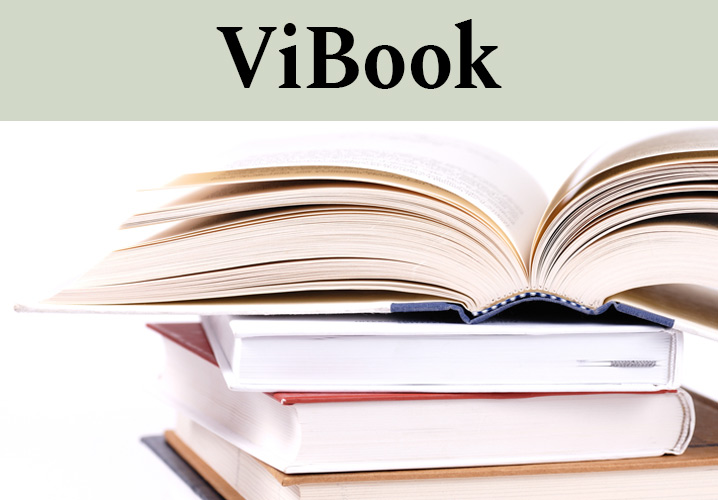Il teatro oggi dovrebbe forse dividersi in due grandi categorie. I classici (inclusi i classici contemporanei) e la ricerca. Da una parte la grande letteratura, i testi fondamentali, gli attori top; dall’altra la sperimentazione, il meta-teatro, i rischi, anche le eventuali cadute. La semplificazione è eccessiva ma è voluta, soprattutto in questi anni che (covid incluso) hanno portato un appiattimento abbastanza pericoloso nel catalogo generale delle proposte. Con accesa curiosità quindi siamo andati al Teatro Astra, venerdì 4 Febbraio per seguire “50 minuti di ritardo” che fin dalla trama prometteva qualcosa di diverso. Lo spettacolo rievoca un’esperienza realmente accaduta a un membro della compagnia veneziana Malmadur su un aereo diretto da Mykonos a Venezia. La partenza fu ritardata di 50 minuti a causa della presenza a bordo di due profughi di circa sessant’anni travestiti da turisti. Solo dopo che furono fatti scendere l’aereo poté decollare. Nessuno dei passeggeri fece nulla.
Nel foyer, degli inservienti (che poi si riveleranno i membri della compagnia) ti chiedono se vuoi acconsentire ad essere inserito in una chat collettiva formata dagli spettatori in sala. Certo che si! Si entra, e… si inizia ad aspettare.

Protagonista è da subito un grande schermo che, sul palco, mostra la chat che già si anima di commenti. Chi si chiede se sia tutto lì, se, di fatto, lo spettacolo sia una chat e null’altro. Chi già la butta sul ridere, chi si accorge che compare il suo nome e si toglie stizzito (ah, la privacy nel 2022, qual problema!).

Poi si inizia sul serio. Viene raccontato l’antefatto che ha portato all’idea del tutto. Attraverso Google Maps ci mostrano come un volo Mykonos/Venezia duri delle ore mentre con l’app ci mettiamo 30 secondi. Siamo sia all’Astra che a Mykonos, questo crediamo sia il senso. Va beh. La storia di Alessia Sacco, la regista di Malmadur che attese sull’aereo, ci viene presentata tra documenti in Text Edit, ricerche su Google, funzioni ed azioni che compiamo decine e decine di volte al giorno, abitudini sia lavorative che riempitempo. La dimensione da ufficio o da solipsismi tecnologici casalinghi, ci mette a confronto con una realtà (la storia in sé) che viene da subito edulcorata dal mezzo. Eppure si parla pur sempre di una situazione grave, del dramma di due profughi che tentano la fuga. Ma pare passare nettamente in secondo piano. A ricordarcelo parte un video in cui c’è una giovane ragazza svedese. Si filma mentre è su un aereo in cui è stato fatto salire un ragazzo che sta per essere riportato nel suo paese per essere processato. Gli steward protestano, così i passeggeri che vogliono solo decollare; la ragazza passa in sostanza per una rompiballe. Alla fine riesce nel suo intento e viene fatta scendere assieme al condannato alla deportazione. Peccato solamente che, qualche giorno dopo il fatto, la protagonista del video verrà multata per il suo comportamento, mentre il ragazzo sarà trasportato nel suo paese d’origine.

Sono due situazioni molto simili quelle in cui si trovavano Alessia e la coraggiosa Svedese. Dell’ultima sappiamo com’è andata. Sulla vicenda di Alessia invece adesso tocca a noi vivere l’accaduto. Siamo idealmente su quel volo. I due profughi compaiono sul palco. Lui e lei, completamente coperti da una calza bianca aderente al corpo. Sono esseri umani, sono fantasmi, sono scarti della società, sono schermi su cui riflettere noi stessi, le nostre bassezze e le nostre idee. Già, le idee. Cosa pensiamo mentre aspettiamo? Parte il countdown. Un grande timer sul palco, al suo fianco lo schermo e in un angolo i due protagonisti letteralmente immobili. Ma i protagonisti siamo noi pubblico. E noi ci muoviamo, eccome. Da quando il tempo parte, cresce il brusio in sala. La consapevolezza che non accadrà altro che attendere la fine dei 50 minuti non suscita reazioni unanimi. Chi protesta sommessamente, chi addirittura dopo poco si alza e se ne va (metà teatro lascerà prima della fine). La chat si infiamma. Qualcuno scherza, qualcuno posta foto di gatti (potevano mancare?), qualcuno la usa per esprimere dissenso. Lo spaesamento si mischia al divertimento. Il cazzeggio cresce. Una ragazza della compagnia passa tra le file con un iPad da cui si può scegliere la musica. Ecco i Maneskin, poi pezzi da Sanremo (che sta andando in onda nello stesso istante), poi di nuovo i Maneskin. Noi ci lanciamo con un Bowie d’annata e la sua “Rebel, Rebel” perché ci pareva ci stesse bene. Gli attori interagiscono col pubblico: fanno foto e video che vanno subito proiettati, usano ogni tipo di applicazione per riempire lo schermo. Qualcuno urla: “ma se ci parlassimo?”. Qualcun altro cerca di attirare l’attenzione dei due immobili attori sul palco che ora fungono da “schermo umano” avendo immagini di ogni tipo proiettate sui loro corpi, così come i volti del pubblico sulle loro facce. Perché loro sono anche noi, e viceversa. La chat inizia a perdere partecipanti: alla fine rimarranno in meno di 40 sui 200 iniziali (la sala invece contava un 300 presenti). Arrivano gli ultimi dieci secondi, la platea scandisce il conto alla rovescia come una liberazione. Fine.

Abbiamo atteso anche noi la fine, come impazienti di decollare. Ma il nostro non era un volo, non era nulla. Volevamo finisse per uscire, per tornare a casa a vedere Sanremo o per andare a bere da qualche parte. Volevamo finisse e che i due attori/profughi si levassero di torno permettendo il proseguire delle nostre vite normali. Mentre abbiamo atteso abbiamo giocato, abbiamo sbuffato ma non ci siamo interrogati su altro che non fosse l’attesa stessa. L’esperimento è riuscito ma non vi erano dubbi. Si sarebbe potuto parlare di più dell’urgentissima questione profughi ma i protagonisti eravamo noi, non loro. Noi che di loro ci interessa meno dell’ascoltare i Maneskin sperando il tempo passi in fretta.