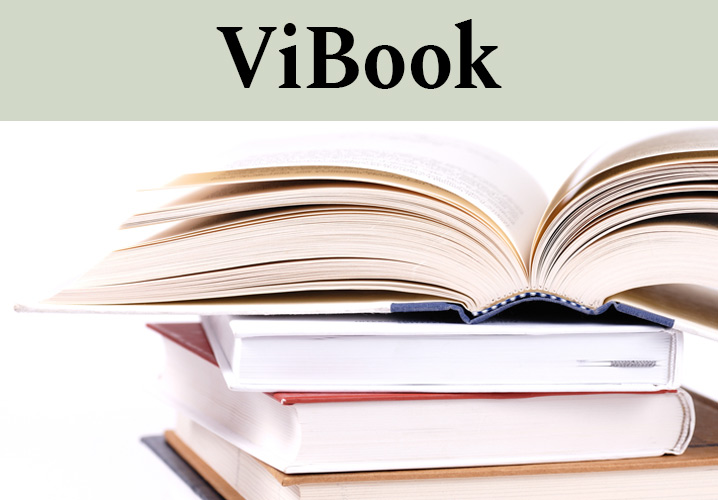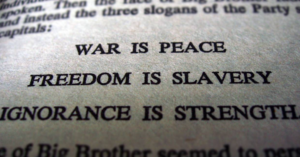Il passato di Vicenza è ormai noto a quanti, accademici o semplici curiosi, abbiano avuto occasione di cimentarsi con la storia della nostra città, le testimonianze che lo scorrere dei secoli ci ha elargito, i mutamenti che le grandi vicende continentali hanno portato anche qui, nella minuscola ma dignitosa vita di provincia. Tutti, persino i turisti stranieri che fanno il loro compiacito ritorno a casa, il gusto del bacalà che persiste sul palato, in testa i paroloni della guida e nel cuore le meraviglie rinascimentali, conoscono Palladio e la grande architettura senza la quale Vicenza oggi, probabilmente, non sarebbe oggetto di tanta ammirazione, in patria e all’estero. Nessuno, o quasi, si interessa del periodo anteriore o posteriore il secolo XVI, generando anche nei vicentini più documentati l’errata convinzione che la storia di Vicenza sia solo Palladio e affini. Miopia elefantiaca quant’altre mai, essa ha portato accademici e memorialisti a crogiolarsi nell’ineluttabile rassegnazione che tutto ciò che c’era da indagare sia stato scoperto, sedendosi su lavori di ricerca compilati decenni or sono, che dunque abbisognerebbero quanto meno di aggiornamenti o integrazioni, o non espletati affatto. Ne derivano gravi lacune, che non sarà difficile ravvisare a chiunque lavori nel campo storiografico. Tra le più gravi è quella relativa al periodo antico, che lungi dall’essere trascurabile è altresì di grande importanza per gli sviluppi successivi della città berica, a partire dall’introduzione del suo nome: Vicenza, che deriva dal latino Vicetia. Sì, noi vicentini abitiamo una città di fondazione romana sin dal nome con cui ci identifichiamo, che se tornassimo indietro non troveremmo neppure nei pensieri più deviati dei nostri progenitori paleoveneti, quando non esisteva una città, ma un minuscolo insediamento ai piedi dei colli, immerso nelle più sperdute campagne della Gallia Cisalpina. Vivere allo stato brado di caccia e raccolta di frutti e bacche, qualche allevamento e capanne sulle agitate rive dell’Astico: un paesaggio che certamente avrebbe affascinato il Virgilio delle Bucoliche, tuttavia, anche qui vi fu chi trovò una città di legno e la ricostruì di marmo. La storia di Vicenza e quella di Roma s’incontrarono una prima volta nel 222 a. C., quando gli abitanti della prima parteciparono al contributo fornito dai Veneti alla guerra della seconda contro i Galli Insubri, che culminò vittoriosamente con la battaglia di Clastidium, che spianò ai romani la strada per Mediolanum, già allora centro padano di fondamentale importanza strategica. Sconfitti gli antichi signori della pianura, l’ingerenza della Repubblica negli affari dei suoi villaggi, che intrattenevano ottimi rapporti anche con la seconda potenza del tempo, gli Etruschi, s’accrebbe in corrispondenza del consolidamento di Roma come primo soggetto politico e militare della Penisola. Infatti, basta mettere in relazione la data della vittoria in Gallia con uno dei fatti più rilevanti della storia romana, la Seconda Guerra Punica, che consacrò definitivamente Roma quale dominatrice dell’intero bacino Mediterraneo e che fu combattuta tra il 218 e il 212 a. C., per accorgersi di quanto la speculare vicenda degli insediamenti veneti andasse di pari passo con i successi militari della Repubblica. Nel 148 a. C., quindi intorno alla metà del II secolo, fu costruita la Via Postumia, impontente asso viario che congiungeva Genua con Aquileia, consentendo a soldati e mercanti di percorrere l’intera Transpadania in relativa sicurezza e con altrettanta rapidità. Probabilmente, si tratta della prima impronta lasciata da Roma nella storia di Vicenza, che fino a quel momento si era svolta, se si esclude Clastidium, entro il circoscritto ambito geografico e politico locale, non curandosi di vicende esterne alla sua realtà. La Via Postumia rappresentò, per il villaggio veneto, un’epifania come poche altre: ruppe il suo isolamento, sbalzandolo di colpo sul proscenio della grande storia, innalzandolo a snodo di riferimento e sosta quasi obbligata per tutti coloro che attraversavano la pianura, meta di scambi commerciali e sede di guarnigioni militari. Un’impronta, la Via Postumia, che è stata regalata a noi vicentini di oggi e che i secoli hanno trasformato nel fulcro della nostra vita dentro la comunità urbana, in uno dei simboli della città e nella meta di peregrinazioni quotidiane. Molti lo ignorano, ma si tratta di Corso Palladio. Il tratto vicentino della Postumia attraversava l’abitato e la città gli è cresciuta attorno, facendo dell’antica opera romana la strada principale di quello che oggi è il nostro arcinoto Centro storico. Ciò dimostra che, a dispetto diquanto si creda generalmente, un periodo storico tanto remoto può lasciare testimonianze di sé talmente attuali che il tempo, lungi dallo scalfirne l’importanza l’ha addirittura moltiplicata, sovrapponendo al sedimento originario secolo su secolo, architettura su architettura, spazio urbano su spazio urbano da cullarci nell’illusione che tali testimonianze non esistano più e un dato luogo sia nato come lo conosciamo oggi. Invece, a volte, basta solo aguzzare la vista per scoprire mondi altrimenti nascosti, per accorgersi che non tutto è come ci appare, che ci sono infinite dimensioni ripiegate l’una nell’altra e che il potere di rievocarle tutte e di riuscire a controllarle, facendo di un singolo luogo uno stimolo per l’immaginazione, è il bello del fare lo storico. Messa in comunicazione Vicenza, che ancora non era tale, con la restante parte dei dominii romani, fu solo questione di tempo prima che seguissero ulteriori novità che avrebbero segnato per sempre la sua storia. A provocarle, nuovamente, furono eventi bellici: nell’89 a. C., all’indomani della vittoria di Roma nella Guerra sociale che la oppose a quasi tutti i popoli che in precedenza gli erano fedeli, e nella quale non mancò l’apporto decisivo di truppe volontarie raccolte dai Veneti, tutti gli insediamenti padani ricevettero in premio la Lex Pompeia de Transpadanis che estese a quei territori il diritto latino, trasformandoli in nuove colonie romane. Qurant’anni dopo, nel 49 a. C., fu Cesare in persona a regolare la condizione giuridica dei Veneti, estendendo a tutti loro la cittadinanza romana come ricompensa per l’aiuto fornitogli nella guerra civile contro Pompeo (49- 45 a. C.): il villaggio berico divenne municipium de optimo iure e godette dei diritti civili e politici garantiti dallo ius romano, potendo al contempo conservare le proprie magistrature, non essendo stato vinto con la forza delle armi, ma essendosi dato al potere di Roma, accettandolo quale federatore e protettore. Una prassi, quella di consegnarsi a un soggetto politico-militare più forte, che Vicenza non avrebbe esitato a riutilizzare nel corso della sua storia. Con la trasformazione in municipium muore il villaggio, nasce la città. Risale a quel tempo la prima comparsa del nome latino Vicetia, le spelonche in legno vengono abbattute e sostituite con quelle in pietra e laterizi, mentre prende forma il nuovo impianto urbanistico, secondo i dettami di Roma: furono tracciati assi il più possibile ortogonali (in realtà la conformazione del territorio li rese per lo più obliqui) intersecati tra loro a formare una maglia e suddivisi in cardines e decumanes a seconda dei punti cardinali da dove partivano e fino a quali muovevano: i primi scorrevano da nord a sud, i secondi da est a ovest. Cuore di questa fitta trama di assi viari sui quali la città stava sbocciando era sempre il tratto della Via Postumia che percorreva l’abitato tagliandolo in due sezioni: a questa fu dato il nome di Decumanus maximus, lungo il quale s’intrecciavano tutti gli altri, come affluenti di un unico grande fiume. Anche il fascio dei decumani ebbe il suo asse principale, che s’incontrava col decumano più grande alla metà del suo percorso, attraversandolo da nord a sud. Se il primo è oggi Corso Palladio, il secondo è diventato una delle contrade più eleganti del Centro storico: come non riconoscere subito, in tale descrizione, Corso Fogazzaro? Resti della sua antica pavimentazione sono stati riportati alla luce e oggi fanno bella mostra di sé affianco alla Chiesa di San Lorenzo: tutti, con un po’ d’attenzione, possono individuarli e osservarli da vicino.

Ecco che le opere secolari della Vicenza romana si rivelano alla nostra vista e scopriamo che erano sempre stati lì, davanti ai nostri occhi intenti ad ammirare un palazzo o un colonnato di epoca successiva, sotto i nostri piedi inerti nel percorrere cento volte al giorno la stessa via senza una rivelazione sconvolgente che potesse ispirarli a farlo un domani con ben altro passo: essa, ora, c’è. Le nostre “vasche”, scommetto, avranno da oggi un sapore speciale. Le meraviglie di Vicetia sono appena cominciate: a questo punto ci si chiederà dove fosse situato il Foro. Ebbene, ricerche archeologiche degli anni Cinquanta ne hanno rinvenuto parte della pavimentazione, scavando in Contrà Cavour, vicino alle fondamenta di Palazzo Trissino-Baston. La scoperta ha portato gli studiosi a ipotizzare che l’antico foro si estendesse lungo la porzione centro-occidentale di Piazza dei Signori e presentasse due aree distinte: l’una, leggermente sbalzata rispetto al volume originario del terreno, ospitava templi e numerosi altre architetture monumentali, l’altra, più bassa, era destinata alla politica e al commercio. I tesori più consistenti di quell’epoca lontana, che stiamo or ora cercando di far rivivere, sono però concentrati poco lontano: sotto alla Cattedrale di Santa Maria Annunciata, per gli amici il “Duomo”. Nel 1954, durante il lungo e tortuoso restauro post-bellico, mentre gli operai erano intenti a ricavare uno spazio sotterraneo per le cantine della nuova canonica, scoprirono un intero criptoportico perfettamente conservato, facente parte di una domus del I secolo d. C., purtroppo andata perduta. L’area archeologica che ne è emersa copre in estensione quasi tutta la piazza del Duomo, a 6,31 m di profondità e si compone di tre bracci a singola navata, sormontati da una volta a botte realizzata in opus coementicium, a formare una grande U. La pavimentazione è costituita da un mosaico di esagonette in laterizio, ricavate a mano dal singolo mattone prima della cottura: al centro di ogni esagonetta è stata posta una tessera bianca di pietra bianca, che, intervallata da una tessera nera, crea nel complesso estetico del pavimento un’interessante bicromia. Il criptoportico, costruzione estremamente rara nell’Italia settentrionale, aveva una triplice funzione: ospitare derrate alimentare e altri materiali deperibili, isolare i pavimenti superiori bagnati d’acqua impedendo infiltrazioni di umidità e fornire un riparo per il freddo, con la sua temperatura mite, durante la stagione rigida. Dopo la grande scoperta, fu realizzato un varco d’accesso che da una rampa di scale conduce nel sottosuolo della piazza, consentendo a turisti e cittadini di ammirare la Vicetia sotterranea. Qui, però, non possiamo esimerci dal formulare una critica al modo con cui enti museali e istituzioni culturali della città abbiano finora gestito un sito così importante. Il criptoportico, la cui accessibilità da parte del pubblico dipende dal Museo Diocesano, è chiuso tre giorni su sette, l’area archeologica ha poca visibilità e ciò dipende dalla scarsa pubblicizzazione imputabile alle varie amministrazioni che si sono succedute. Inoltre, le visite sono effettuabili solo previa prenotazione, presso un numero telefonico che fa capo al suddetto ente museale, senza la possibilità, per chi ne abbia voglia, di poter usufruire con efficacia di un servizio culturale che appartiene a tutti. Il criptoportico rappresenta bene lo stato dell’arte per quanto riguarda la gestione e promozione delle vestigia romane a Vicenza. È stata l’inedia degli amministratori a consentire quella, successiva, degli studiosi e insieme hanno provocato un diffuso sentimento di noncuranza verso questa pagina di storia che è la prima causa del dimenticatoio nel quale essa è stata sospinta, estirpata dalla coscienza collettiva. Di Vicetia si parla talmente poco, e talmente male da poter prevedere che non diventerà un tema di confronto politico e culturale in seno alla società vicentina da qui al prossimo secolo. Non ci si illuda che piazzando qua e là totem con quattro acche stampate sopra possa conquistare turisti e cittadini: i totem si corrodono col tempo, simbolo di una memoria che si perde nelle ambasce d’una vita che non concede più il lusso di fermarsi e leggere qualche riga di storia, in italiano od inglese. Serve ripensare completamente l’impianto museale, affidarsi a una pubblicità moderna e intuitiva, che possa colpire con immediatezza il pubblico medio e specie i giovani, spesso avulsi dal mondo della cultura locale. Serve dialogo con associazioni del settore, con volontari che possano assicurare l’erogazione delle visite ogni giorno e non solo a chi si prenota in anticipo, ma a tutti, a chiunque passi di là, se necessario attirandolo dentro col megafono. Serve un confronto con gli attori del mondo accademico, che porti a nuove ricerche, al finanziamento di pubblicazioni corrette, alla mobilitazione di giovani laureati che potrebbero far da guida a chi ha si vorrà lasciar conquistare da questo patrimonio obliato. Serve, insomma, che si faccia qualcosa, rompendo un indecoroso silenzio che dura da decenni. Per completezza, bisogna dire che la maggior parte dei reperti rinvenuti nel sottosuolo è visitabile al Museo Archeologico di Santa Corona, ma anche quei locali, oltre che di un ammodernamento interno, abbisognerebbero di maggior promozione. Una critica, se formulata senza propositi offensivi o distruttivi, può far molto: staremo a vedere. Vicetia, comunque, non era solo il suo foro o le sue domus: nel I secolo d. C. era una media città dell’impero che aveva raggiunto il prestigio sufficiente a dotarsi di un teatro. In un’area che oggi pullula di contrade medievali e dimore signorili, compresa tra contrà Porton del Luzzo e contrà Santi Apostoli e concentrata in Piazzetta San Giuseppe, è ancora ben ravvisabile la foggia dell’antico Teatro di Berga. Infatti, osservando la disposizione degli odierni palazzi, l’uno costruito affianco all’altro senza soluzione di continuità, si noterà la forma di un semicerchio: la cavea. Penetrando tra cortili e cantine, i più fortunati riuscirebbero persino a toccare la pietra utilizzata dai romani per la sua costruzione. Qui, fino al III secolo d. C. avevano luogo gli spettacoli e si ritrovavano i membri dell’aristocrazia terriera, ma anche professionisti, come avvocati o ricchi mercanti dell’età imperiale. La scena, composta di marmi policromi, non ha resistito all’incombere del tempo, ma numerose statue si sono salvate e sono visitabili presso il Museo Archeologico. Vicetia non ebbe una grande importanza strategica, ma diede comunque i natali a diversi personaggi di secondaria, ma rilevante, importanza per la storia di Roma, come il grammatico Quinto Remmio Palemone e il generale Aulo Cecina Allieno, che combattè al fianco di Vitellio durante la lotta per la successione di Nerone, nel 69 d.C., il cosiddetto “anno dei tre imperatori”. In particolare, il giurista Gaio Salonino Patriuno, che fu pretore e console, era padre di due auguste: marito di Ulpia Marciana, sorella dell’imperatore Traiano in persona, ebbe una figlia, Salonina Matilda: da quest’ultima discendono gli imperatori Marco Aurelio e Commodo, che quindi avrebbero ascendenza “vicentina”. Se mi si consente l’espressione, direi che è una gran figata tutto ciò. Un’altro segno del periodo romano che val la pena di citare è l’acquedotto, che portava l’acqua dalle campagne a nord fino in città: in località Lobia ne è ancora ben visibile una modesta, ma perfettamente conservata, porzione. Inoltre, sue fondamenta sono riscontrabili transitando i portici settentrionali di Corso Fogazzaro, in direzione della Chiesa di San Giacomo: lì, il pavimento lascia posto a lastre di vetro che rivelano la presenza dei basamenti in pietra dell’acquedotto. Anche l’atrio, sempre aperto al pubblico, di Palazzo Da Schio, ospita lapidi in pietra e cippi d’età romana che possono essere visitati in qualunque momento, fermandosi al civico 147 di Corso Palladio: uno di essi è un miliario che risale al periodo costantiniano e reca incisa la seguente dedica all’imperatore: “D(domino) N(ostro) Flavio Constantino Maximo Pio Felici Invicto Augusto VII”. La cifra romana alla fine indica la distanza in miglia da Vicetia espressa dal cippo: in questo caso sette, perché fu ritrovato a Montecchio Maggiore. Insomma, la storia di Vicetia, sotterranea e dimenticata, lascia grandi sorprese a chi è disposto a documentarsi. Si tratta di un territorio ancora vergine, che la ricerca dovrà prima o poi incaricarsi di esplorare a fondo, facendo emergere la gran parte di quel mondo che giace ancora relegata ai confini dell’immaginario pubblico di noi vicentini, sepolta da metri di terra e da migliaia di pensieri futili. Chi, amministratore o studioso, riuscirà a promuovere questo nuovo corso della cultura, recherà un servizio a Vicenza quale la nostra comunità non ha mai incontrato: libererà non solo dalle tenebre una pagina di storia, ma ne aprirà una nuova circa la gestione del patrimonio di storia antica che trasformerà radicalmente la nostra città, con nuove iniziative e magari l’apertura di nuovi enti museali o spazi urbani, accrescendo la fama di Vicenza non solo come città del Palladio, ma come urbs a Romanis condita. Noi ce lo auguriamo.