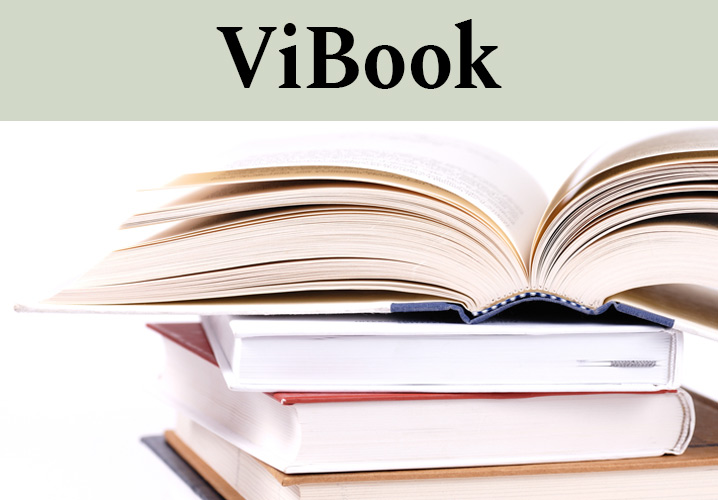“Ci si vede l’anno prossimo” si diceva ieri. Anche ad amici che vedi in ogni caso il giorno dopo al solito posto alla solita ora. Ma il giorno dopo il Vicenza Jazz non ci sarà più, per quello si deve attendere un anno. E quando “ci si vede” durante il festival è come essere in vacanza, è come abitare una casa in cui non hai domicilio. Sono stati giorni bellissimi, bagnati per lo più, partecipati per quanto fosse possibile. Ci rimangono immagini e ricordi che non sbiadiranno presto. Le sorelle Labèque e la loro perfezione, il suono delle voci sarde riempire di carezze la vastità del cimitero notturno, le tablas di Trilok Gurtu, due ombrelli persi, le birre ghiacciate al Teatro Astra, la commozione pura di fronte ad Abdullah Ibrahim, quell’ora di trascendenza con Zoe Pia e Mats Gustaffson, le corse tra un locale e l’altro, i pasti al volo di giorno e quelli a tarda notte, un teatro pieno di gente in piedi che balla la taranta, la magia degli spazi ipogei di Palazzo Thiene. Non c’è un singolo evento che diremmo “superiore” sebbene in cuor nostro qualcosa di più grande ci sia stato. Ma un festival è tutto il pacchetto, anche le cose meno riuscite.
L’ultima giornata, baciata dal sole, è stata una sarabanda posizionata in un piano inclinato che volgeva verso il commiato. I “Volcano” altro non sono che i Vertical con le camicie colorate. Loro avatar reali in versione cazzeggio apparente, che si spiaggiano in piazza delle erbe e fanno ballare anche la Torre del Girone. È la leggerezza dell’ultimo giorno di scuola, con il pomeriggio troppo azzurro e lungo per te, che tra poco parti le spiagge e senti fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va…
Al Bamburger in scena Santucci feat. Gnesotto & Brunetta con un trio bizzarro formato da sax, percussioni e giradischi (!). Caraibi e Africa, Cuba e Capo Verde, una cultura melange di danzereccio contagio.
Al Pestello il Grazia Di Grace Duo con alcuni brani dei più grandi compositori della musica swing americana degli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso (Gershwin, Porter, Rodgers and Hart, Ellington per citarne alcuni).
E poi la sera, la conclusione, il commiato, che non è stato festoso ma intimo, colto e meditativo. Al Teatro Olimpico le “Quattro Stagioni” di Vivaldi hanno preso nuova vita tra nuovo e antico: da un lato l’interpretazione della violinista Sonig Tchakerian – solista e direttore dell’orchestra di Padova e del Veneto – che del capolavoro vivaldiano offre un’interessante e riuscita lettura, e dall’altro Pietro Tonolo che realizza un’operazione indovinata, rielaborando e parafrasando materiale vivaldiano in un originale gioco di specchi, dove si fronteggiano il barocco veneziano, il jazz e una vena improvvisativa a tema, basata su sonetti che rimandano liberamente ai sonetti originali delle Stagioni.
Termina così un’edizione che è stata coraggiosa e sfortunata. Coraggiosa perché il programma si è (finalmente, aggiungeremo) allontanato dal mainstream e ha portato alcuni eventi di assoluta rilevanza artistica e contemporanea. Sfortunata perché il tempo ha impedito alcuni concerti e soprattutto ha di fatto abortito il jazz club pensato al giardino del Teatro Astra. Permetteteci di ringraziare Riccardo Brazzale e Luca Trivellato e tutti i collaboratori di questo giornale coraggioso e sfortunato (a noi chi a culo sta sullo stomaco) che è stato privilegiato per 11 giorni nel seguire ed inseguire bellezze che ci hanno scaldato il cuore. That’s all folks! Sipario.