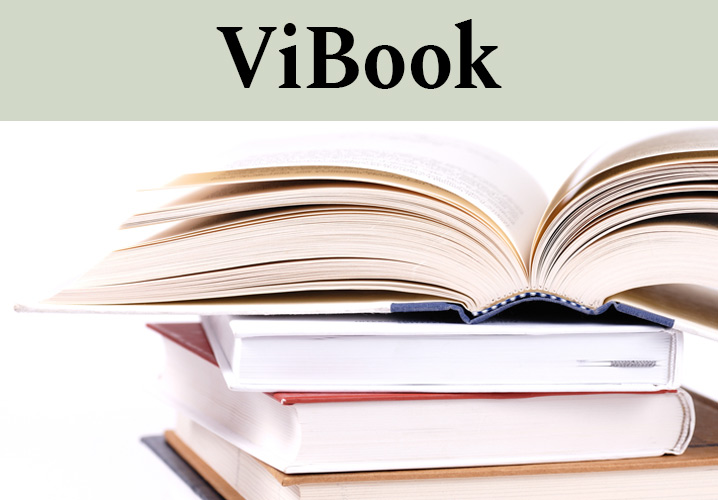Risulta difficile pensare ad altro in questi giorni. Complesso anche solo il mero esercizio di distrazione.
Con il cuore in Ucraina, almeno la mente cerca di rimanere qui, e andare a vedere Silvio Orlando pare una
scelta magnifica per sviare dai tormenti. Lo spettacolo che il grande attore napoletano porta al Teatro
Astra di Schio è una sua riduzione del magnifico romanzo di Romain Gary “La vita davanti a sé”, edito
per altro dalla vicentina Neri Pozza. Il testo uscì nel 1975, quindi in un’epoca che oggi pare lontanissima,
eppure è incredibilmente attuale e per certi versi ideale per raccontare il nostro presente. La storia del
ragazzino Momò, musulmano e abbandonato, che cresce con Madame Rosa, impegnata nel tirar su i
marmocchi di prostitute che non possono accudirli, nel quartiere multietnico di Belleville, a Parigi, è
poetica e struggente. Momò è affamato di attenzioni, in un mondo fatto di disagio, di estrema solitudine,
ma in cui trova le ragioni per sperare, per capire, per amare finanche. Se avete letto il libro sapete di che
parlo, ma anche fosse, andate a vedere questo spettacolo perché il lavoro di Orlando è semplicemente
magnifico. Riesce a ridurre il romanzo dandogli una sequenza narrativa e drammaturgica snella e leggera.
Un’ora e mezza senza prender fiato e alla fine sei lì, commosso, che vorresti andasse avanti per chissà
quanto ancora. Tutto è perfetto. La scena onirica con un condominio di carta e poche luci. L’Ensemble
dell’Orchestra Terra Madre che è essenziale quanto profonda nei suoi interventi. E lui, soprattutto lui, che
giganteggia affrontando tutti i personaggi (Momò in primis ovviamente) e ridendo, piangendo, ballando,
fissando il mondo con quei suoi occhi incredibili.
Abbiamo avuto il privilegio di parlargli e questa è la breve chiacchierata che ne è uscita.

Innanzitutto complimenti anche per “Ariaferma” che è un film stupendo.
Ma grazie, (sorride), così si che si inizia bene!
Veniamo a “La vita davanti a sé” e iniziamo dalla fine, da quel “bisogna voler bene” che è l’ultima frase
dello spettacolo. Mi è parsa perfetta per definire questo momento.
Viviamo dentro a problemi enormi e a storie che vengono da lontano. Trovo molto difficile sbrogliare la
matassa. Quello slogan è una provocazione. In questi ultimi anni il cinismo va molto di moda e si finisce
spesso per venire tacciati di essere anime belle. C’è costantemente il rischio della retorica in ogni
posizione, e all’interno dello spettacolo quella frase è una sfida. Il senso è: possiamo avere armamenti e
tecnologie ma se non c’è l’amore non si va da nessuna parte. Mi riferisco ovviamente a quanto sta
accadendo. Quando un dittatore è dentro ad una bolla di consenso ed è circondato da gente che gli dà
sempre ragione, inevitabilmente perde il contatto con la realtà e col fattore umano. E nel caso di Putin, si
tratta di un pazzo. Però noi siamo presi da una febbrile necessità di essere originali e controcorrente, tipo
“mi si nota di più se parlo bene della Russia o male dei vaccini?”. In questo temo sarà sempre peggio.
Momò è un ragazzino molto particolare. Come stanno i ragazzini del mondo secondo lei? Non solo i tanti Momò ma i ragazzi di ogni ceto e fortuna. Anni fa gli adolescenti avevano molti attori come idoli ed esempi, più indietro nel tempo anche molti eroi dei romanzi. Oggi tra social, influencer e cattiva tv chi seguono?
Spero ci siano dei Silvio Orlando giovani che riescano a parlare ai giovani. Io faccio quello che posso, ma
non ho il linguaggio e gli strumenti per capire cosa passa nella testa di un ragazzino di 12 anni. Non so
cosa sarebbe oggi Momò e me lo chiedo sempre mentre faccio lo spettacolo. Qualche anno fa forse lo
avremmo immaginato come un integralista islamico, oggi probabilmente sarebbe in una baby gang. Io
penso che Momò sia figlio di quei tempi (gli anni del libro) in cui era più facile fare degli incontri che ti
salvavano. Le banlieue erano all’interno delle città mentre invece adesso abbiamo creato dei mostri
urbanistici in cui i ragazzi non riescono ad avere una prospettiva e ad incontrare persone che abbiano una
storia diversa dalle loro. Oggi se nasci a Tor Bella Monaca sei condannato a rimanerci e questo provoca
rabbia. I miti di oggi sono irraggiungibili ma molto presenti allo stesso tempo. Il problema è che creano
solo una dimensione delirante di vicinanze o di sogno che però non si realizzerà mai.

Qui siamo a Schio, che è provincia di una provincia come Vicenza. Lei queste dimensioni le conosce
bene, girando in lungo e in largo lo stivale. Come vede la provincia oggi, e che idea ha della nostra? Mi sembra che dentro ai vostri territori lo shock della crisi crei la paura di perdere il benessere. La
provincia però rimane salvifica secondo me. Hai la sensazione che esista più prossimità, che i luoghi
siano più a misura d’uomo rispetto alle megalopoli. Mi sembra che la dimensione della provincia sia più a
livello di inclusione con i problemi, che così, forse, diventano più risolvibili.
Nel bis l’abbiamo vista in un ruolo insolito. Non sapevo fosse un novello Ian Anderson.
Eh eh, la musica dei miei tempi. Beh suonicchio il flauto traverso, male, ma lo faccio. E quindi mi
piaceva molto l’idea di concludere uno spettacolo così delicato e per certi versi anche triste, con un gioco
collettivo. E poi ci tenevo a dare la scena ai miei musicisti che se la strameritano. La musica unisce
sempre.
Nella sua opera c’è sempre quella vena un po’ malinconica, disincantata ma allo stesso tempo speranzosa, sia nel dramma che nella commedia.
Guarda, i vincenti mi annoiano, non li trovo interessanti. Tra uno sfigato di insuccesso e un pirla di
successo starò sempre con lo sfigato. Un vincente pensa di non essere sfigato ma spesso è un pirla. Io
penso di essere antropologicamente legato a quelli lì. Non ci ragiono nemmeno sopra. Dialogo con quelli,
faccio fatica a trovarmi nel carro del vincitore e non vedo l’ora di scenderne. Sono stato su dei piccoli
carretti a volte, ma mi sentivo sempre a disagio. Prima di essere buttato giù, scendevo io.